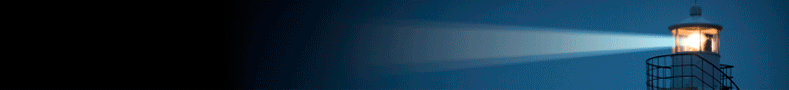
Ai Lettori
Secondo Piano News non riceve finanziamenti pubblici come i grandi e piccoli media mainstream sovvenzionati a pioggia dallo Stato. Pertanto chiediamo ai nostri lettori un contributo libero che può permetterci di continuare a offrire una informazione vera, libera e corretta.

Luigi E. Pizzolato per l’Osservatore Romano
Già molti decenni fa, Romano Guardini (Il Signore. Riflessioni sulla persona e sulla vita di Gesù Cristo, traduzione italiana: Milano, Vita e Pensiero, 2005, pagine 341-348, ma l’originale tedesco è del 1937) aveva istituito un accostamento tra la parabola del “figlio perduto” (o del “Padre misericordioso” o del “figlio prodigo”: Luca, 15, 11-32) e quella del “padrone della vigna” (o degli “operai dell’ultima ora”: Matteo , 20, 1-16), accomunate da un finale dove sembra scoppiare uno “scandalo” per la giustizia.
Nella parabola del “figlio prodigo” i diritti della giustizia sono reclamati dal fratello maggiore, che trova scandalosamente difforme il trattamento di favore riservato al fratello ritornato rispetto a quello a lui riservato dal padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora…» (Luca, 15, 29-30).
Nella parabola del “padrone della vigna” sono gli operai assunti per primi che giudicano scandalosa l’equiparazione della loro retribuzione a quella degli operai assunti solo al pomeriggio, cioè alla fine della giornata lavorativa: «Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo» (Matteo , 20, 12).
E Guardini nota che la lettura provoca anche nel lettore un moto spontaneo di resistenza che il fedele reprime non convintamente, ma solo per rispetto e fiducia nell’autorità di chi (Gesù) l’ha proposta. Per lui però lo scandalo è dovuto alla mancata percezione da parte dei protestatari e del lettore della gerarchia che intercorre tra giustizia e amore all’interno del messaggio di Cristo. Che se non la si distingue, rappresenterebbe uno scandalo lo stesso compiersi di qualsiasi conversione, visto che «ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione» (Luca, 15, 7).
Oltre che accogliere questa distinzione, si può lavorare più a fondo anche sullo stesso concetto di giustizia. Se essa, intesa nel senso etico tradizionale, è virtù che “dà a ciascuno il suo”, si tratta di vedere con gli occhi dell’amore e di una sana antropologia che cosa comporti quel “suo” che a ciascuno spetta. Possiamo rischiare di chiederci: il “suo” di ogni uomo è quello che attiene alla sua situazione temporanea attuale — quasi in una specie di giudizio anticipato su una condizione sempre precaria e infondata — o alla sua natura originaria e finale di uomo fatto “a immagine e somiglianza”?
Che se del secondo si tratta, il ”suo” che spetta a ciascuno non rientra nella logica valutativa, ma sempre nella prospettiva finale dell’a m o re donato senza calcoli. Comunque resta un’innegabile zona di insoddisfazione istintiva nella percezione di una discrasia tra due realtà positive: amore e giustizia. E ci si chiede se non possano anche in questo caso essere declinate di conserva, senza infrangere la giustezza del senso etico comune. Già il testo evangelico suggerisce che la stessa giustizia, in quanto virtù etica distributiva (non grazioso-oblativa), non è infranta, ma, per così dire, sublimata.
Il padre della parabola lo ricorda apertamente: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo» (Luca, 15, 31). Il figlio che resta in casa ha avuto il continuo piacere dell’unione comunionale col Padre, anche se egli non l’ha magari percepita pienamente, proprio perché era condizione essenziale e non eminentemente distributiva. Il confronto perciò non deve prendere in considerazione solo i due trattamenti diversi finali, ma anche l’insieme delle condizioni, e ciò riequilibra in qualche modo il senso della giustizia distributiva.
Già nel De beata vita (1, 2) Agostino, ragionando sul tòpos classico della vita umana come navigazione, contempla anche il caso di chi è sempre rimasto in prossimità del porto sicuro (sua madre Monica, ad esempio), distinguendoli da quelli — dei più? — che se ne erano allontanati e vi sarebbero rientrati sospinti da quella che, col poeta, potremmo chiamare «provvida sventura».

È una sventura che per lo più ridesta nei lontani — come nel figlio prodigo — la nostalgia della casa paterna. Non a caso la parabola del figlio prodigo è discretamente ma significativamente sottesa agli inizi delle Confessioni (I, 17, 27- 18, 28; ma anche III, 4, 7) col movimento dell’«alzarsi» (surgere ) e del «tornare» (redire ), che è quello stesso del figlio prodigo: Surgam et ibo (Matteo , 15, 18).
Essa getta luce evangelica su quel meccanismo del ritorno dell’uomo al porto o a casa che è indicato come inquietudine, che è posto quasi a epigrafe dell’opera: «Ci hai fatti orientati a Te, e inquieto è il nostro cuore fino a che non trova quiete in Te» (Fecisti nos ad Te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te: Confessioni, I, 1). L’inquietudine non è un dato puramente psicologico o, peggio, un disturbo patologico: esso è piuttosto un dato strutturale dell’uomo.
Il figlio prodigo (ogni uomo in quanto lontano) è inquieto perché è lontano e si ricorda come si stava bene prima e constata la distanza attuale da quella condizione di felicità perduta. L’inquietudine è perciò segno, a un tempo, del ricordo di Dio e della distanza da Lui; e la perenne insoddisfazione dell’uomo nei confronti di ogni meta temporanea ottenuta caratterizza il movimento della vita umana nel tempo. Il cammino di conversione è quindi un ritorno a casa, stimolato dallo stesso principio Padre che ci ha creati e che ha messo nelle nostre fibre la nostalgia di Sé.
L’inquietudine è perciò il modo e il meccanismo strutturale e originario con cui Dio fa tendere a Sé l’uomo e lo recupera a Sé, senza bisogno di interventi spettacolari di recupero, facendogli avvertire con il senso di mancanza la sua imperfezione e con il dolce ricordo il suo destino di perfezione. Lo recupera, insomma, mediante il mistero della stessa struttura desiderante dell’uomo, cioè della sua aspirazione inesausta alla felicità, che è a dire della comunione con Dio. E l’inquietudine trova sbocco finale nella buona accoglienza da parte del Padre, che ripristina con un risarcimento straordinariamente concentrato quella condizione di dolce relazione che era costantemente e normalmente “diluita” nella condizione del figlio rimasto in casa.
E se il padre è «dolce» quando dà al figlio, si fa ancora «più dolce» la sua accoglienza proprio perché il figlio «ritorna bisognoso» (egeno redeunti dulcior: Confessioni, I, 18, 28). Ma la conclusione ribalta più radicalmente ogni logica quando afferma: «Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi» (Matteo , 20, 16). Perché non invocare almeno una par condicio tra operai ultimi e primi, invece che, addirittura, una “preferenzialità ” verso gli ultimi? Qui, a mio avviso, può entrare in gioco il parallelismo con la parabola del figlio prodigo e con la festa maggiore che si fa in cielo per il peccatore che si converte. [quote] Gli operai assunti per primi sono stati in realtà avvantaggiati perché hanno risolto subito il loro problema vitale [/quote]Insomma, con la predilezione per gli ultimi in quanto già segnati dal dolore e dalla debolezza. Siamo consapevoli di azzardare, ma ci chiediamo: gli operai assunti per primi non sono stati in realtà già avvantaggiati perché hanno risolto prima il loro problema vitale e dispiegato più estesamente la loro natura attiva, più tipicamente umana dell’inoperosità degli ultimi che il vangelo chiama argòi , “senza lavoro”?
Non sarà che — come il fratello maggiore del figlio prodigo — anche i primi operai sono già stati favoriti perché hanno più a lungo usufruito della sicurezza e del contatto col padrone buono? E hanno beneficiato del rapporto di attività e di uno status, ben più consoni all’uomo che il ludibrio dell’inoperosità esposta in piazza? Bisogna considerare l’effetto economicistico del lavoro (per cui chi produce di più merita maggiore retribuzione) o l’aspetto antropologico di realizzazione umana che il lavoro comporta, per cui esso va riguardato come una specie di diritto? Secondo la stessa logica che comanda la privilegiata accoglienza del figlio prodigo da parte del padre, potremmo chiederci allora se gli operai assunti per ultimi non siano stati risarciti dal padrone per la loro incolpevole inoperosità e umiliazione, con una bontà maggiore che configura una specie di “sussidio di disoccupazione”.















